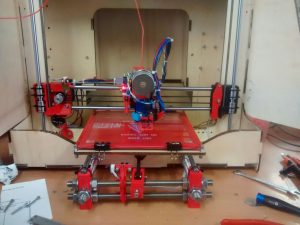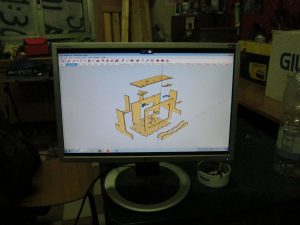«Ti piacerebbe di andare nello specchio? […] Fingiamo che lo specchio sia morbido come un velo, e che si possa attraversare. Toh, adesso sta diventando come una specie di nebbia… Entrarci è la cosa più facile del mondo.»
– Lewis Carroll
Un momento dopo Alice attraversava lo specchio e, spinta dalla curiosità, si ritrovava in un mondo tanto fantastico quanto denso di pericoli. Non serve un grande sforzo per immedesimarsi in Alice: la delusione di una realtà sbiadita, la voglia di ampliare la nostra percezione, il fascino di un mondo ignoto ed esclusivo, il desiderio di spingere la potenzialità umana oltre il proprio orizzonte, sono tutti elementi caratterizzanti della nostra condizione esistenziale, ben radicati nella nostra fantasia fin dall’infanzia.
È a partire da questi elementi che Charlie Brooker costruisce l’universo in cui è ambientato “Black Mirror“. Proprio come Alice, infatti, rimaniamo affascinati dalle potenzialità offerte dallo “specchio” moderno dei nostri smartphone, con una differenza importante: lo specchio di oggi non è più una superficie perfettamente riflettente, anzi è opaco, o meglio nero, quindi totalmente assorbente.
Mentre per Alice lo specchio offre una finestra su un sogno, un capitombolo in una realtà parallela, autonoma, e del tutto indipendente dalla realtà quotidiana, nel mondo contemporaneo lo schermo nero non viene attraversato, ma inglobato nei nostri corpi, e allo stesso tempo esso ingloba noi, riflettendo ma ridefinendo costantemente la nostra identità.

La distinzione fra sogno e realtà, fra reale e virtuale, si opacizza e sbiadisce sempre più velocemente, mentre di pari passo si assottiglia la discrepanza fra corpo organico e corpo macchinico. Lo tecnologia ci trasforma, lo smartphone diventa un nostro “arto”, che ci consente di arrivare dove prima non potevamo, o meglio un “organo“, che svolge determinate funzioni in sintonia con gli altri organi, diversi solo per tessuto, con cui scambia stimoli e segnali. Ma tutti gli organi devono fare riferimento a un centro di controllo, il nostro processore di informazione ed elaborazione, più potente di qualsiasi smartphone o computer, grazie alla sua struttura neurale rizomatica, il cervello.
Ma per quanto tempo ancora il nostro cervello può reggere il confronto con le macchine? Certamente esistono delle funzioni che prima erano appannaggio esclusivo del cervello e che sono adesso gestite in modo più efficiente dalle macchine. Un esempio su tutti: la memoria. I nostri pensieri, le nostre immagini, i nostri impegni, sono ormai sempre più spesso spesso memorizzati su supporti elettronici. Azzardando, ma neanche troppo, potremmo affermare che le macchine oggi sanno di noi più di quanto ne sappiamo noi stessi. Direte voi: dov’è il problema? Se le macchine sono organi, dovranno pur svolgere la loro funzione!
Di problemi ce ne sono tanti. Anzitutto chi gestisce le macchine? Chi le produce? E perché lo fa? Appare indubitamente ammaliante percepire la tecnologia come l’emancipazione progressiva dell’umanità dalla schiavitù della propria fragile natura, come il trionfo della tecnica che espande costantemente l’orizzonte attuale oltre i limiti imposti. È la parola stessa, nel suo originale greco, a ispirare questo concetto: “τεχνολογία” (leggi tékhne-loghìa) significa letteralmente “discorso, ragionamento, sull’arte” e conserva, nella sua essenza, un tratto ideologico, offre una prospettiva per il nostro divenire, per la nostra evoluzione come collettività. Ma si spinge oltre: propone di discutere, di ragionare, ci esorta a capire dove stiamo andando e dove vogliamo andare, suggerendo che il nostro spazio di espansione non sia necessariamente unidimensionale, ma che sia in qualche modo delineato razionalmente. La tecnologia pensata e descritta come strumento di liberazione, in sé, per sé, di tutti, per tutti, dell’umanità, per l’umanità. Ma perché allora ci interroghiamo sulla bontà delle macchine? Siamo veramente certi di avere degli strumenti che ci portano alla libertà e non alla schiavitù?
Per prima cosa dobbiamo riconoscere che la tecnologia non è mai stata solo un discorso, un’ideologia, ma anzi un processo, un’attività umana che in quanto tale è soggetta ai cambiamenti della società in cui è immersa. Se inizialmente l’esigenza era quella di condividere e tramandare alla comunità una serie di tecniche e conoscenze per non perderle nel tempo e migliorare la vita futura oltre alla propria, oggi questa stessa attività è incardinata saldamente al vertice del capitalismo, e si sostanzia nella produzione di brevetti, licenze, proprietà intellettuali e sistemi sempre più sofisticati e innovativi di occultamento della conoscenza. L’avanzamento del progresso tecnologico, del potenziamento delle macchine, è affidata a soggetti privati, sempre più esclusivi, grandi colossi multinazionali, che operano segretamente all’interno delle proprie divisioni innovatrici, spesso zone militarizzate, risoluti a non divulgare niente se non il loro prodotto finale. In sostanza, si può affermare che la tecnologia abbia subito una deriva “autoritaria“, nella misura in cui demandiamo a delle “autorità” non collettive la funzione di produzione e spesso di gestione delle macchine, e quindi del loro ruolo nel futuro immaginario dell’umanità.
Non essendo un sistema gestito collettivamente, bensì competitivamente, non esiste quindi né un orizzonte, né una prospettiva a cui tendere, che sia comune o collettivo, e che non sia soggiacente agli interessi particolari dei soggetti sempre più elitari che lo agiscono.
Infatti, l‘idea che le macchine vengano ideate e migliorate per sopperire a un bisogno umano è tanto pura quanto ingenua; la tecnologia è spesso spinta da interessi più meschini. Per fare un esempio potremmo descrivere l’allunaggio del ’69 come un grande passo in avanti del progresso umano verso l’esplorazione spaziale, oppure come l’interesse di un gruppo ristretto di uomini di mostrare la propria supremazia tecnologica ad un altro gruppo ristretto di uomini.
Oggi l’avanguardia del progresso tecnologico, non guarda più verso il cielo. Il bisogno “da soddisfare” è stato sostituito dal bisogno “da instillare”, di generare un desiderio all’interno del soggetto, ora consumatore, producendo gadget sempre più sofisticati. Gli apparati con i quali ci confrontiamo oggi, che sono entrati pervasivamente a far parte di noi, nativi digitali, che già ci sembrano imprescindibili, rispondono all’esigenza del mercato di vendere i loro prodotti a singoli individui. “Divide et impera” oggi si legge “changing the world – one person at a time“. Oggi la tecnologia è di “tutti” – certamente, solo di chi se lo può permettere – e solo nel suo prodotto finale, chiuso e inscatolato.
Chi ne ha veramente il controllo non siamo noi, confinati come siamo nel nostro ruolo di fruitori di merci. Questi dispositivi sono “nostri”, nel senso che invadono il nostro corpo, ma non “nostri” nel senso di averne la piena gestione, o sicuramente la abbiamo fino a un certo punto. Ad esempio, possono all’occasione diventare raffinati strumenti di sorveglianza e controllo, o meglio di disciplina dei soggetti.
Il pericolo che queste tecnologie siano in mano a soggetti spregiudicati, accecati dalla loro sete di potere, è uno dei temi più trattati dalla fantascienza cyberpunk.
Sembra abbastanza per trasformare il sogno in un incubo, ma il mondo di Black Mirror sembra volersi distaccare dalla distopia quasi necessaria del passato. Il mondo futuro non è così distante dal presente, e non è neanche così cupo e autoritario. I soggetti della serie sono spesso imprudenti ma non necessariamente sprovveduti, almeno nella misura in cui si trovano già all’interno di un sistema organizzato, con dei limiti definiti per le loro azioni.
Sicuramente cerca di far emergere le asimmetrie evidenti presenti in un sistema diviso fra chi gestisce una tecnologia e chi ne usufruisce, esasperando giustamente le contraddizioni di un mondo ormai sempre più connesso fra corpi e macchine, ma senza necessariamente trascurare le relazioni fra i corpi e i corpi.
Black Mirror ha il grande pregio di affrontare un tema delicato, la transizione al transumanesimo e i problemi bioetici che ne conseguono, senza scadere nel luddismo, senza ricorrere cioè alla distruzione delle macchine “padroni dei nostri corpi” per proporre un ritorno alla vita “genuina”, ricordando spesso come la macchina è in fondo sempre uno strumento, ora di emancipazione, ora di schiavitù, ma chi la gestisce rimane squisitamente umano.
Si offre inoltre da interprete per un fenomeno complesso come l’innovazione tecnologica, proponendo un punto di vista obliquo nei confronti degli agenti protagonisti di essa: del mercato che la genera, della pubblicità, dei mass-media, dello Stato, cercando di immedesimarsi in un soggetto comune, per far capire come spesso la tecnologia possa essere uno strumento per implementare dei meccanismi di dominio “ingenuo“, apparentemente vantaggiosi per il singolo, entusiasta di un arricchimento digitale invasivo, ma che risulta a volte inaspettatamente tragico.
In conclusione, la serie risulta convincente non in quanto scientificamente accurata o straordinariamente visionaria, ma poiché si relazione all’uomo ordinario, alle emozioni e alle paranoie presenti in noi ieri, oggi e domani. Sicuramente offre dei buoni spunti per valutare con più consapevolezza l’uso che facciamo delle tecnologie attuali, all’impatto che hanno sulle nostre vite e sui nostri corpi senza necessariamente demonizzarle, dei meccanismi che soggiaciono l’intrattenimento, l’individualizzazione, le reti sociali, senza trascurare temi “classici” come il lavoro e la giustizia, sfruttando il futuro per agire sul presente.
– Rugantio